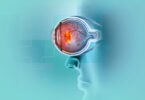27 Settembre 2024 ![]()
Quel sabato mattina era iniziato come tutte le giornate di lavoro: sveglia alle sei e trenta, rapida doccia, uscita in villa di un’ora con l’amato beagle Zap, chiacchiere e passeggiata con gli altri amici canari, ritorno a casa, colazione e via in bicicletta, come al solito, di nuovo attraverso la villa, verso l’ospedale. Era una fredda mattina di febbraio con un’aria cristallina, una luce abbagliante, radente, limpida, nordica. Il sabato è la giornata che noi ciclisti urbani preferiamo: poco traffico, pochi automobilisti da prevenire ed evitare. Alle nove, di buon umore aprii la porta tagliafuoco del reparto, quella pesante in ferro, con un piccolo vetro al centro che permette di vedere uno spicchio del corridoio della corsia. Vidi qualcosa di strano ma la rapidità del gesto di aprire la porta non mi permise di mettere bene a fuoco ciò che avevo intravisto. Quando l’apertura fu completata mi apparve il lungo corridoio luminoso e vidi bene ciò che avevo intuito: in mezzo al corridoio, di fronte alla porta della stanza degli infermieri stava, in piedi, un uomo, nudo, sporco, che trascinava in terra la sacca delle urine e che, in una lingua incomprensibile, sicuramente dell’Est Europa, urlando e farfugliando apostrofava non si sa chi. Avvicinandomi vidi le classiche stigmate dell’homeless: la pelle grigiastra del collo, i capelli lunghi e appiccicati tra loro, le unghie delle mani e dei piedi lunghe, nerastre. Bastò guardarlo di profilo per comprendere anche la sua malattia: sopra due gambe sottili, prive di muscolatura si ergeva trionfante un addome gonfio, rotondo, teso: l’immagine che nei vecchi libri di patologia, facendo riferimento ad una descrizione dantesca, veniva riportata come quella di un uomo “fatto a guisa di leuto”. Cirrosi epatica con scompenso, verosimilmente da abuso alcoolico.
“Lo ha portato un’auto della polizia stamattina alle sei. Si aggirava in piazza dei Cinquecento dicendo parole incomprensibili e sconclusionate. Abbiamo cercato di lavarlo e lo abbiamo messo a letto con le sbarre, ma le ha scavalcate e ora eccolo qui” fu il rapido e preciso resoconto degli infermieri.
Ora che il nostro ospedale ha l’onore delle cronache è giusto ricordare come, non solo il nostro, ma forse un tantino più degli altri, fosse considerato in alcune circostanze una sorta di cassonetto sociale dove buttare alcune situazioni in cui si intrecciavano patologie mediche e sociali. L’odore si faceva sentire. Lì per lì maledissi il momento in cui avevo deciso di andare in ospedale quella mattina ma ero stato tentato dal sapere che, eccezionalmente, saremmo stati in tre quella mattina e avremmo potuto finire in ora decente, magari per le due. Si lavora meglio, si dividono le cose da fare senza affanno. L’espressione degli infermieri era un misto di rassegnazione, pietà e rabbia, immaginando molte delle cose che sarebbero avvenute come un film troppe volte già visto.
Il tempo di cambiarmi e di dire ai miei colleghi, appena arrivati anche loro: “Abbiamo una bella grana”.
L’uomo, se quello era un uomo, fu rimesso a letto e mi colpì il fortissimo contrasto tra il colore del suo viso grigio giallastro e il candore delle lenzuola. Farfugliava, era scosso da tremore e contrazioni del viso e degli arti. Un misto tra insufficienza epatica grave e astinenza alcoolica. Il tempo di dare un’occhiata alla cartella, cercare di acquisire alcune notizie e le sue generalità che, come prevedibile, perse conoscenza e precipitò nel classico coma epatico.
“Almeno starà fermo e potremo cercare di curarlo” fu la realistica comunicazione che con uno sguardo ci scambiammo. Il coma durò tre giorni durante i quali come al solito ci impegnammo tutti, medici ed infermieri. Ci si impegna sempre al massimo ma in quell’occasione come in molte situazioni disperate forse si mette un po’ di più, come a voler lottare contro un destino sfortunato, per dare una possibilità anche remota di riscatto e, chissà, quasi per il desiderio di riequilibrare un po’, almeno in quel periodo, i piatti della bilancia della vita. Si risvegliò dopo tre giorni. Il risveglio dei malati dal coma, di qualsiasi origine esso sia, è un momento di grande emozione. Si osserva la riemersione da una dimensione incognita e lontana, si incrocia uno sguardo che faticosamente mette a fuoco l’ambiente, i visi delle persone che sono intorno mentre la mente cerca di recuperare una dimensione spazio-temporale.
Iniziò quindi l’usuale, in questi casi, periodo di conoscenza reciproca, di accettazione di un particolare approccio da parte nostra e di alcune regole da parte sua. Non sapevamo neanche il nome e, scherzosamente, lo ribattezzammo Ivan, perché aveva passato certamente momenti terribili. Nei limiti del possibile iniziò a migliorare. In pigiama e tute da ginnastica nuove provenienti dalla riserva della corsia, iniziò ad alzarsi, a fare qualche passeggiata nel corridoio riservato ai parenti, prendeva con cura le medicine e ai pasti il solito quartino di vino rosso che la cucina aggiunge, su nostra richiesta, nei casi di alcoolismo. Emerse con il tempo anche una sua certa conoscenza dell’italiano. Raccontò di essere in Italia da oltre sette anni e di aver vissuto sempre “on the road”. La stazione era la sua casa, il mondo il suo nemico, il vino il suo compagno abituale, il cartone ed una lisa coperta scozzese il suo calore. La tirò fuori dell’armadio dove stava appallottolata in un angolo mostrandocela come un cimelio di guerra, lisa, con buchi e rattoppi. Aprì poi il cassetto del comodino e ci mostrò una spiegazzatissima fotocopia di un passaporto polacco. Fu una rivelazione. Per noi una traccia da seguire. Immediata telefonata al nostro assistente sociale: “Stefano abbiamo una traccia per il nostro Ivan. Vieni appena possibile.” Oltre alla possibilità di fare alcune ricerche quel fatto costituiva anche un buon motivo per far proseguire la sua degenza in reparto, superando le poco convinte pressioni del primario per la dimissione e i limiti draconiani del DRG. Intanto il nostro Ivan, continuerò a chiamarlo così, si integrava sempre più nella routine ospedaliera svolgendo anche qualche piccola attività in aiuto del personale di assistenza che a lui, come noi, si stava affezionando lentamente. Emersero alcuni lati del suo carattere docile ed altruista. Ricordo come si prendeva cura di un anziano ricoverato nella stessa stanza che era immobilizzato a letto. Stefano fu bravissimo. Dal documento e con l’aiuto dell’ambasciata polacca, potenza del Papa polacco a cui fu chiesto aiuto dalla comunità di S. Egidio di cui Stefano faceva parte, si poté ricostruire la sua origine.
“Stefano a che punto sei? Guarda che qui non potremo resistere a lungo per la dimissione!” era la solita telefonata mattutina.
“Ci lavoro tutti i giorni. Faccio passi avanti, ma lentamente” la usuale risposta.
Una mattina Stefano entrò raggiante in reparto: “Ho trovato la famiglia. Vivono in Italia, nelle Marche, ho parlato con la moglie e la figlia. Non lo vedono da molti anni, più di dieci, da quando lasciò la famiglia per problemi di lavoro e alcolismo. Si sono anche loro trasferiti in Italia e vivono a San Benedetto del Tronto dove lavorano e hanno una bella casetta. Sono disposti a venire a trovarlo e forse a prenderlo con loro”.
“Sabato prossimo sono di guardia tutta la giornata. Dì loro di venire nel pomeriggio così li facciamo incontrare.” Stefano telefonò di fronte a me e organizzò l’incontro. Il dubbio se preannunciare la cosa a Ivan era forte. Decidemmo per un’operazione di aggiramento studiando le sue reazioni, parlando con lui della famiglia, dei suoi ricordi e, perché no, dei suoi sensi di colpa nei loro confronti. Il rimpianto era il suo sentimento prevalente. Non rivelammo i nostri programmi. Il sabato pomeriggio, giunti all’ora X, chiesi al collega che era di guardia con me di concedermi un po’ di tempo per affrontare la situazione. Arrivarono la moglie, una donna sulla cinquantina, minuta, occhi chiari accompagnata da un giovane sulla trentina, una ragazza bellissima con occhi chiari, capelli lunghi e biondi, un viso e un accento dolcissimo tra il marchigiano ed il polacco, con il suo fidanzato. Parlammo per una buona mezzora, prima con una fitta serie di domande su Ivan, sul perché fosse finito a fare quella vita, su come stesse in salute. Non detti molte speranze sulla sua aspettativa di vita ma dissi che in quei oltre 40 giorni di ricovero mi sembrava molto cambiato e desideroso di continuare su quella strada. Giunsi quindi al momento più delicato “Noi dovremmo dimetterlo, ovviamente con terapia e controlli a domicilio, ma abbiamo aspettato perché non avremmo voluto rimetterlo in strada. Voi cosa mi dite?”
Il primo a prendere la parola fu, inaspettatamente, il giovane uomo “Ivan è il padre della mia fidanzata che non è qui per lavoro. Noi lo accoglieremo con piacere nella nostra casa. Questo è il desiderio di tutti”
Pronunciò queste parole con una semplicità e dolcezza che mi colpirono molto. E mentre parlava mi colpirono i suoi occhi, scuri, sinceri, profondi. “Sabato prossimo, se Ivan accetterà, vorremmo venire tutti a prenderlo”.
Ero veramente colpito da questa risposta, abituato, come ero in circostanze simili, ad intavolare lunghe trattative con i parenti del malato per stabilirà la data di dimissione. Significava tante cose: affetto, responsabilità, senso della famiglia, altruismo, comprensione. Dissi loro di aspettare e, entrato nella stanza, dissi ad Ivan che era venuto a trovarlo qualcuno che non vedeva da molto tempo. Non dimenticherò mai le espressioni di Ivan, incredulo, commosso, sinceramente sorpreso. La moglie gli si avvicinò e si strinsero in un abbraccio liberatorio che sembrava spazzare via anni di lontananza e di dolore. Venne il momento dei regali che purtroppo dovetti far restituire: mortadella a pezzi, salumi vari, formaggi salati e piccanti. Tutti inadatti alla dieta di Ivan ma nel tipico stile dell’Est. Mi allontanai lasciandoli alla loro ritrovata intimità. La settimana successiva volò e ci accorgemmo di un ulteriore cambiamento in Ivan: sempre perfettamente rasato, pulito, raggiante insomma felice. Il sabato successivo venne anche la figlia. Pensai che anche a tutto ciò si dovesse la grande disponibilità del fidanzato, senza alcuna idea di sminuire il valore della sua decisione. Lasciarono il reparto felici ed anche noi, con il pensiero, eravamo diretti a San Benedetto del Tronto. Ci sentimmo per telefono e tutto procedette bene sino ad una mattina di tre mesi dopo quando la moglie ci comunicò la morte improvvisa di Ivan. Disse però che sia Ivan che tutta la famiglia avevano trascorso un periodo di perfetta armonia e serenità e che erano felici per la possibilità che avevano tutti avuto. Questa è una storia in cui la malattia ha rappresentato un’occasione di redenzione, di recupero di affetti lontani e allontanati, di generosità, di legami che non si cancellano pur di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili. Mi è tornata in mente in questi giorni difficili di pandemia e morte, di familiari che non riescono a rivedere i propri cari nemmeno negli ultimi momenti. È un periodo questo in cui violenza, dolore e morte sembrano dominare la scena, ma ci sarà tempo di ricordare anche momenti di dolcezza e di solidarietà che ora affogano in questo mare di numeri, morti, lacrime.